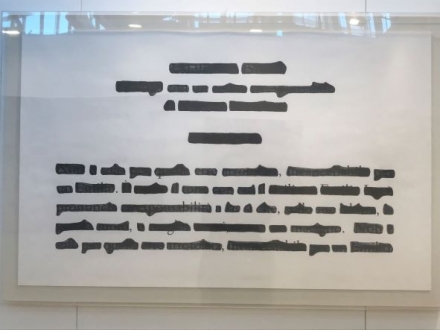28 anni dopo
Il primo capitolo di una nuova trilogia tra alti e bassi stratosferici.
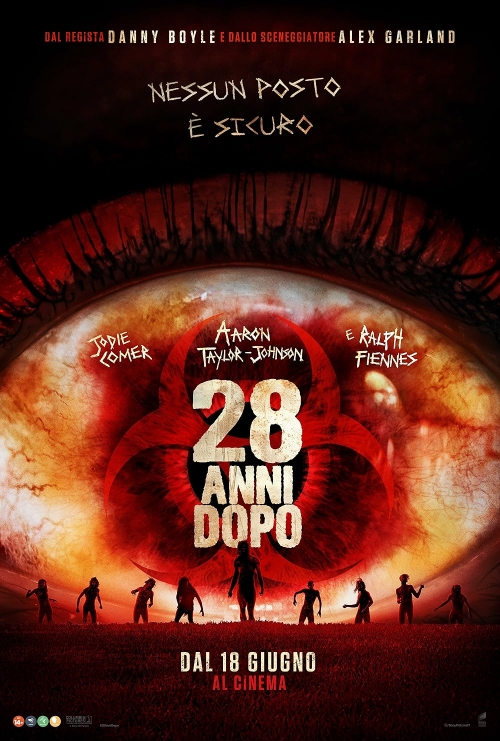
Il virus della rabbia, dopo essersi diffuso in tutta Europa come narrato dal finale del precedente 28 settimane dopo (2007), è stato sconfitto.
La Gran Bretagna invece, per motivi non meglio precisati, è stata abbandonata a sé stessa e messa in stato di quarantena, pattugliata da navi che si assicurano che nessuno lasci l’isola.
28 anni dopo, il nuovo capitolo della saga, primo di una preannunciata trilogia, dà l’impressione di essere il risultato, non del tutto riuscito, di un tentato compromesso tra le diverse visioni del regista Danny Boyle e dello sceneggiatore Alex Garland, già responsabili del primo episodio.
Il film, infatti, è perfettamente diviso in due parti che sono l’uno lo specchio dell’altro.
Al centro il più tipico viaggio dell’eroe con relativa presa di coscienza e maturazione, una sorta di percorso iniziatico che segna il passaggio dall’infanzia all’età adulta con tutti i topoi del genere, compresa l’uccisione metaforica del padre, il superamento del complesso di Edipo e chi più ne ha ne metta.
L’eroe in questione è il dodicenne Spike (Alfie Williams) che vive con il padre Jamie (Aaron Taylor-Johnson) e la madre Isla (Jodie Comer) in una comunità autosufficiente, ripiombata in una sorta di medioevo, arroccata sull’isola di Lindisfarne.
Per il ragazzo è giunto il momento del rito d’iniziazione tipico della comunità, avventurarsi sulla terraferma insieme al padre.
In questo primo viaggio ritroviamo lo stile classico di Danny Boyle così come abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni.
Montaggio ipercinetico in pieno stile da videoclip anni ‘90 che alterna vorticosamente materiali diversi e detta il ritmo dell’azione anche grazie ad uno strepitoso comparto sonoro.
Boyle accosta le immagini di cavalieri medievali armati di frecce a quelle di marce militari che richiamano il nazismo e frulla il tutto mescolandolo con le avventure dei due.
A fronte però della perizia registica la vicenda è quanto di più banale si possa immaginare, siamo in territori a metà strada tra The walking dead e Last of us (videogioco e serie tv).
Il tutto visto e rivisto e sembra più che altro una scusa per introdurre i vari infetti; i “lenti-bassi” che strisciano e si cibano di vermi ed i più veloci capitanati dagli “alfa”, super massicci ed intelligentissimi.
Spike riesce a tornare alla comunità, celebrato come un eroe, ma il contatto con il mondo esterno, soprattutto il fumo visto in lontananza, e la scoperta che probabilmente esistono altri sopravvissuti, gli instilla il tarlo del dubbio.
Così il nostro decide di fuggire, insieme alla madre malata, alla ricerca del mitico Dottor Kelson (Ralph Fiennes).
Comincia così un nuovo viaggio che è il vero cuore pulsante del film e che è sia la parte più interessante sia il vero e proprio percorso che porterà Spike ad una nuova consapevolezza.
Il ragazzino imparerà a vedere il mondo con occhi diversi, quelli di Kelson, mentre verrà approfondita la mitologia degli infetti che, nel frattempo, si sono organizzati anch’essi in vere e proprie comunità ed hanno anche cominciato a riprodursi.
La storia dunque si sviluppa lungo due temi fondanti; da una parte c’è il discorso sulla famiglia che trova il suo apice nelle bella sequenza dell’infetta che partorisce aiutata da Isla, dall’altra il punto di vista di Kelson che, al contrario degli abitanti della comunità dalla quale proviene Spike, rappresenta un approccio scientifico ed umanista nei confronti degli infetti.
Il tutto culmina con il rito che avrebbe potuto essere il perfetto finale del film nel quale Spike abbandona definitivamente l’infanzia imparando a conoscere la morte e l’amore.
Nel mezzo però, non mancano le cadute di stile, a partire dalla parte riguardante i soldati finiti sull’isola a causa di un naufragio, introdotta da uno dei peggiori stacchi di montaggio che si possano ricordare.
Qui si sente pesantemente la mano del regista e l’insieme appare inserito a forza, senza un vero e proprio senso, se non quello di dare delle informazioni, tutto sommato superflue, su come sia andata avanti la vita al di fuori della Gran Bretagna.
Inutile cercare delle letture metaforiche, che pure abbondano, dal parallelismo con la Brexit alla riflessione sul nostro mondo nel post pandemia; a nostro avviso 28 anni dopo non parla di questo ma semmai, appunto, del crescere affrontando il dolore e la perdita.
Peccato che il tutto venga rovinato, ancora una volta, da un finale ignobile e kitsch oltre ogni limite che sembra, ancora una volta, frutto della sola mente di Danny Boyle.
A questo punto non resta che aspettare i prossimi capitoli, soprattutto il terzo, ancora in fase di scrittura e sul quale non sembrano esserci idee troppo chiare.
EMILIANO BAGLIO