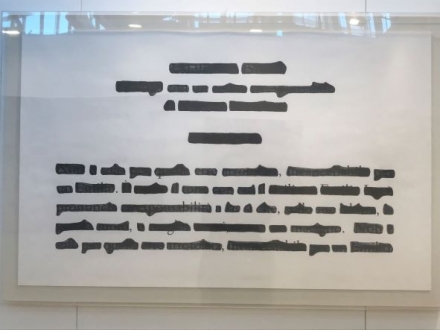Coronavirus e i palcoscenici vuoti. Il Teatro si fa a teatro. Una rappresentazione on-line non potrà mai essere un nuovo modo di fare teatro

L'emergenza sanitaria per il Covid-19 ha posto la classe dirigente italiana davanti a scelte difficili, obbligandola a ricorrere a strumenti eccezionali con l’obiettivo primario di salvaguardare il diritto alla salute. Tra questi, lo strumento più in voga è senza dubbio la piattaforma digitale, grazie alla quale molte attività e servizi possono continuare a essere praticati nel rispetto delle norme di sicurezza. Persino il mondo del teatro è interessato – seppur con molte perplessità – dalla diffusa digitalizzazione, entrando così in conflitto con una virtualità che ne stravolge funzione ed essenza. La situazione diventa ancor più preoccupante quando si trascura il carattere eccezionale degli strumenti impiegati per fronteggiare l’emergenza, auspicando un uso ordinario e generalizzato dei mezzi tecnologici, spesso glorificati da una fede acritica nel progresso. «Non sempre ciò che vien dopo è progresso» – direbbe Manzoni (in questo periodo va molto di moda) e sarebbe opportuno aggiungere: «… soprattutto dopo un'emergenza sanitaria».
Le dichiarazioni rilasciate dal Ministro di Beni culturali e Turismo Dario Franceschini, nel corso della trasmissione “Le parole della settimana” condotta da Massimo Gramellini, hanno suscitato apprensione nel mondo dello spettacolo: «Stiamo ragionando sulla creazione di una piattaforma italiana che consenta di offrire a tutto il mondo la cultura italiana a pagamento, una sorta di Netflix della cultura, che può servire in questa fase di emergenza per offrire i contenuti culturali con un'altra modalità, ma sono convinto che l'offerta online continuerà anche dopo: per esempio, ci sarà chi vorrà seguire la prima della Scala in teatro e chi preferirà farlo, pagando, restando a casa».
Gli operatori dello spettacolo – non soltanto attori e registi, ma anche ballerini, musicisti, scenografi, costumisti, tecnici – perdoneranno l’uso dell’espressione “Netflix della cultura”. L’emergenza impone di pensare a nuove modalità di diffusione della cultura pur di garantirne la fruibilità. Circa il 90% dei lavoratori dello spettacolo, infatti, è fermo, con una perdita calcolata di circa 20 milioni di euro la settimana per un totale di 150 milioni stimati alla data del 19 aprile. Danni irreparabili per il settore dello spettacolo, tamponati da strumenti provvisori e precari. È pur vero che tutta questa attenzione momentanea per la cultura rivela, in realtà, anni di svilimento del settore artistico, sotto il profilo della tutela dei lavoratori che operano in tale ambito, del finanziamento statale e del riconoscimento sociale dell’arte e degli artisti. Gli operatori dello spettacolo non potranno di certo perdonare che – una volta superata l’emergenza – gli strumenti eccezionali per farvi fronte diventino la regola, snaturando l’identità del teatro come luogo fisico e privandolo della sua funzione essenziale: porre l’uomo davanti a se stesso, alla sua indifferibile dimensione umana.
Troppe volte il teatro è stato confinato nella sua (nobilissima) funzione di divertimento, considerata futile e superflua, in un’ottica materialistica in cui non c’è spazio per chi non “produce”. Eppure, il senso proprio del termine “divertire” è “volgere altrove” e il teatro fa della creazione di un “altrove” la sua missione quotidiana: è soltanto altrove che l’uomo riesce a indagare – a volte più consapevolmente, altre meno – se stesso, estraniandosi dalla sua realtà e immergendosi in un’altra. Se il teatro trasporta in un altro mondo lo spettatore ha vinto. Anzi, gli spettatori. Perché il teatro, ricordiamolo, è un fatto collettivo, non individuale. Si respira tutti insieme, si ride e si piange tutti insieme, non per uno spirito di condivisione fine a se stesso ma perché la consapevolezza di una comunità si forma attraverso la relazione con l’altro e non tra i muri di casa davanti a uno schermo. Il teatro è un’arte fatta di corpi, nella quale l’uomo ha contatto diretto con il dolore o con la gioia, con la rabbia o con la paura, sentimenti che impara a conoscere e comprendere perché il suo corpo li percepisce da un altro corpo che piange, che ride o che si arrabbia, nel buio di una platea di persone che aspettano, come bambini, che accada qualcosa e qualcuno volga lo sguardo dentro di loro.
La questione è di primaria importanza: non si tratta di assumere o meno una posizione refrattaria nei confronti dell’evoluzione tecnologica – la quale comporta indubbiamente dei vantaggi – in nome di un nostalgico desiderio di conservazione quanto, piuttosto, di preservare la natura di determinati mestieri e attività che, attraverso il ricorso alle piattaforme digitali, perderebbero la loro funzione sostanziale. Acquistare un biglietto di uno spettacolo teatrale da vedere a casa non è e non potrà mai essere un nuovo modo di fare teatro, perché del teatro non rimarrebbe nulla. Per di più, tale congegno determinerebbe l’intrusione nel teatro della trappola capitalistica, la quale è solita indurre strategicamente i bisogni e, dunque, fornire le soluzioni ai problemi, in un circolo vizioso e irrefrenabile. Si pensi, per esempio, al desiderio frenetico di avere più comodità, appagato – apparentemente – dalla possibilità di monetizzare tempo e spazio in cambio di comfort domestico, in una dimensione individualistica nella quale prospera il capitalismo. Il teatro, di contro, si nutre di persone e di collettività. Senza di esse muore.
Qualcuno obietterebbe che gli amanti del teatro potranno continuare ad andarci, così come gli amanti del cinema continuano ad andare al cinema nonostante la concorrenza tra Netflix e sale cinematografiche. Tuttavia, qui si tratta dell’incompatibilità strutturale del teatro – a differenza del cinema – con forme virtuali. Ammettere la coesistenza delle forme virtuali e della rappresentazione tradizionale sarebbe già di per sé una negazione del teatro. Si considerino, inoltre, gli effetti distorsivi che si verificherebbero nel caso in cui non fossero i teatri a detenere la gestione delle piattaforme digitali: le regole di mercato scatenerebbero una “guerra tra piattaforme” con vinti e vincitori, e questi ultimi potrebbero offrire esclusivamente gli spettacoli più graditi alla massa dei consumatori per massimizzare i profitti.
Le dichiarazioni di Dario Franceschini potrebbero rappresentare un punto di non ritorno ed è molto allarmante che sia stato proprio il Ministro di Beni culturali e Turismo – di solito molto illuminato nelle sue scelte – ad avanzare una simile proposta.
È il sintomo che la classe politica italiana non possiede una coscienza artistica ed è responsabile dell’assenza di condizioni entro cui questa potrebbe svilupparsi, senza tralasciare che iniziative di questo genere costituirebbero il trampolino di lancio per un’ulteriore sottrazione di fondi statali alla cultura e all’arte. Non si dimentichi che l’offerta su piattaforme digitali provocherebbe una riduzione progressiva dell’offerta nei teatri – se non, addirittura, la scomparsa – per poter far “rientrare i costi” non finanziati dallo Stato o, comunque, difficilmente sostenibili, in un meccanismo inarrestabile e distruttivo. D’altra parte, lo abbiamo già detto: il capitalismo crea i problemi e offre immediatamente le soluzioni ai problemi stessi, senza darci il tempo di percepire il vuoto.