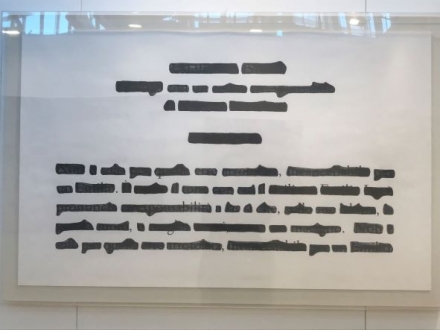Manta ray
Il dramma del popolo Rohingya in un film ipnotico.

Manta Ray, opera prima di Phuttiphong Aroonpheng, è dedicata al popolo Rohingya.
I Rohingya sono una minoranza etnica di religione islamica che vive nel settentrione della Birmania al confine col Bangladesh. Non fanno parte delle 135 etnie riconosciute dalla Birmania e secondo i rapporti delle Nazioni Unite sono una delle minoranze più perseguitate al mondo. La maggior parte di loro vive in campi profughi in Bangladesh, in ghetti o in campi sfollati con il divieto di lasciare questi luoghi.
Dinnanzi ad un opera come Manta ray ci sono due possibilità.
Una è il rifiuto di questo modo di fare ed intendere il cinema, un’opzione perfettamente legittima e, per certi versi, anche comprensibile.
L’altra è abbandonarsi.
La scelta del verbo non è casuale perché Manta ray è quasi la quintessenza di un certo cinema asiatico, antinarrativo per eccellenza.
Lo spettatore che scelga dunque questa via si ritroverà a fare i conti con un flusso ipnotico di scene che scandagliano la quotidianità dei personaggi caratterizzate da un andamento maestosamente flemmatico, con una serie di immagini apparentemente slegate tra di loro che lasciano il campo aperto alle interpretazioni.
Aroonpheng filma i protagonisti della sua vicenda con l’occhio di un osservatore invisibile, quasi un voyeur, che sta attaccato a loro.
Poi improvvisamente li isola, caricando di significato il paesaggio; non solo quello naturale della sua Tailandia, ma soprattutto il paesaggio urbano.
Navi (forse da guerra?) abbandonate a sé stesse, palazzi in costruzione, giostre e fiere in cui inquadrare i volti dei due personaggi principali, l’uno specchio dell’altro.
Un cinema dunque enigmatico e magmatico che pone domande e non da risposte alla nostra ansia tutta occidentale di spiegazioni e di messaggi, magari persino politici dato la dedica del film.
Come dicevamo Aroonpheng sembra quasi rifiutare una narrazione lineare e chiara.
I due protagonisti del suo film non hanno neanche un nome ed uno di fatto è muto.
Chi è dunque l’anonimo pescatore che un giorno trova nella foresta il corpo esanime di un uomo ferito al quale darà il nome di Thongchai?
Forse, l’uno è lo specchio dell’altro e non a caso quando il primo scomparirà Thongchai ne prenderà il posto. Comincerà anche lui a fare il pescatore e quando tornerà la moglie di colui che lo ha salvato si sostituirà al marito, finendo addirittura per assomigliarsi fisicamente a partire dai capelli ossigenati.
Ma cosa faceva esattamente il nostro pescatore; o meglio in quale losca attività era coinvolto, cos’era che gli ordinava di fare il suo misterioso capo e che lui non era più disposto a compiere?
E chi è l’uomo che si aggira circondato di lucine di natale per la foresta?
E da dove vengono quei corpi, quel neonato, che dormono per sempre sepolti nella foresta?
E questa foresta nella quale le pietre di notte prendono vita, emettono luci colorate, smuovono il terreno emergendo allo scoperto, è un luogo reale o solo un sogno?
Ed il finale, misterioso ed incomprensibile, di quest’opera è l’ennesimo sogno di un uomo definitivamente sconfitto, un ricordo sotto forma di allucinazione o una metafora del destino di un intero popolo?
Domande aperte alle quali, se proprio vogliamo, possiamo cercare di dare risposte.
Quello che è certo è che qui, come in Pirandello, abbiamo a che fare con una storia di doppi, di persone che prendono l’identità dell’altro perché non ne hanno più una loro.
Il pescatore e l’uomo salvato possono essere viste, allora, come le due facce della stessa medaglia.
Uomini osservati silenziosamente nella loro quotidianità mentre si guardano/specchiano dall’alto di una giostra.
Potremmo addirittura pensare che vi sia un’attrazione che li lega, mentre ballano l’uno ripetendo i movimenti dell’altro, nella baracca del pescatore trasformata in una discoteca con quelle assurde luci di natale onnipresenti che diventano poetiche macchie di colore che poi vanno ad abitare la notte della foresta.
Forse Thongchai è muto perché quando sei vittima di un genocidio non c’è nulla che tu possa dire. Forse è solo un testimone muto dell’orrore, forse il pescatore riconosce in lui un suo fratello ferito.
Forse il suo è il grido muto di accusa ad un intera nazione, anzi al mondo intero.
Forse quel corpo di neonato nella foresta è uno dei tanti bambini rohingya stappati alle loro case, lasciati morire naufraghi.
O forse bisogna solo smetterla di cercare un senso ed abbandonarsi, come il lento scorrere del fiume, alle immagini, rimanere succubi della loro bellezza. Riscoprire la potenza dell’uomo all’interno del paesaggio come nel migliore Antonioni.
Lasciarsi andare e tornare là da dove si è venuti.
Nel mare, come nel ventre materno, finalmente liberi come quelle mante che vengono continuamente richiamate dal pescatore durante il film e che si sottraggono all’occhio.
Perché dinnanzi all’orrore siamo tutti ciechi e non rimane allora che la poesia di film come Manta ray.
EMILIANO BAGLIO