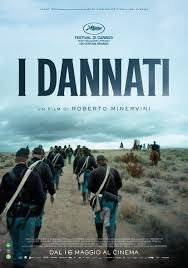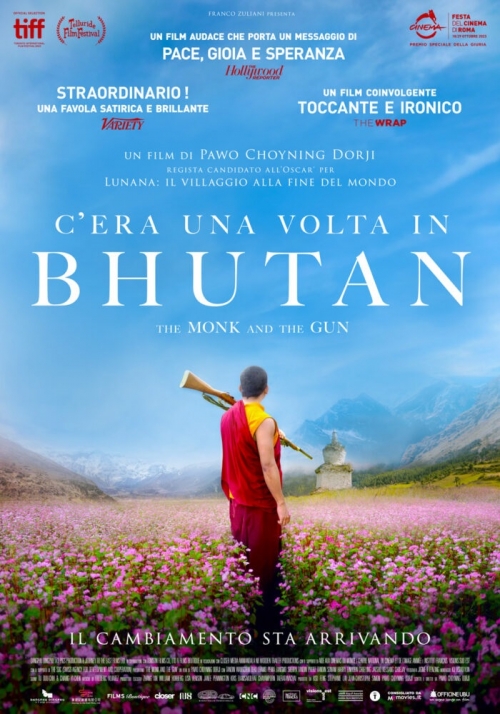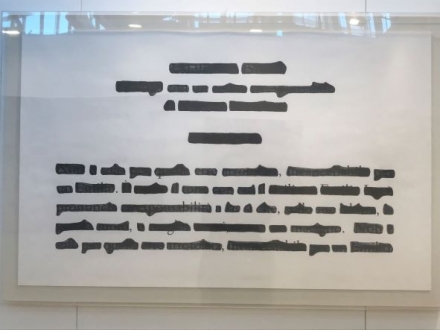Alluvioni, frane, dissesto del territoro. L'Italia del rischio idrogeologico

Quanto accaduto nel Gargano e in particolare nel comune di Peschici non è purtroppo un evento eccezionale, né isolato. Due morti e decine di milioni di danni alle strutture civili, turistiche, alle attività agricole, al paesaggio, alle infrastrutture. Negli ultimi tempi si suole usare le parole bombe d’acqua per definire le devastazioni causate da eventi così drammatici, ma la realtà non è solo quella di un clima che sta cambiando e che avvicina il nostro paese a quelli tropicali; ragione per cui nel Gargano o in Sardegna il novembre scorso, in Sicilia o a Genova, cadono in due giorni i quantitativi di pioggia di sei mesi, ma la realtà è che quella pioggia trova un territorio largamente antropizzato e devastato da abusi, scempi, orrori urbani edilizi di ogni sorta.
Qualcuno, pochissimi tra i politici e gli amministratori, lo sostiene da tempo, quello della cura del territorio è la questione per eccellenza dell’Italia, soprattutto se consideriamo che oltre al rischio idrogeologico elevato è il rischio sismico del paese. Motivo per il quale appare sconcertante l’assenza dall’agenda del governo Renzi, ma in realtà dall’agenda di qualsiasi governo degli ultimi vent’anni, di una concreta politica di salvaguardia del territorio. Se ciò fosse fatto non solo potremmo evitare i lutti e le distruzioni che puntualmente ogni anno colpiscono, soprattutto in autunno, l’intera penisola, ma si riuscirebbero a creare migliaia di posti di lavoro, ecco perché si tratta di una questione determinante.
I dati
Secondo gli annuali rapporti di Legambiente redatti anche grazie ai dati del Corpo Forestale dello stato l’82%, 6600 comuni italiani, è a rischio idrogeologico, una percentuale che ci pone ai primi posti per questo rischio in Europa. Più di 4000 le vittime in mezzo secolo, 6 milioni di italiani che vivono e lavorano ogni giorni in zone ad altissimo rischio. Nella classifica delle regioni a maggior rischio idrogeologico, con il 100 per cento dei comuni esposti, al primo posto la Calabria, poi il Molise, la Basilicata, l'Umbria, la Valle d'Aosta, oltre alla provincia di Trento. Seguono Marche, Liguria con il 99%, Lazio, Toscana al 98%; Abruzzo 96%, Emilia-Romagna 95%; Campania e Friuli Venezia Giulia al 92%; Piemonte 87%; Sardegna 81%; Puglia 78%; Sicilia 71%; Lombardia 60%; provincia di Bolzano 59%; Veneto 56%.
Fra il 1960 e il 2012, tutte le venti regioni italiane hanno subito eventi fatali. 541 inondazioni in 451 località di 388 comuni, che hanno causato 1.760 vittime (762 morti, 67 dispersi, 931 feriti), e 812 frane in 747 località di 536 Comuni con 5.368 vittime (3.413 morti compresi i 1.917 dell'evento del Vajont del 1963, 14 dispersi, 1.941 feriti).
Nel 2013, la popolazione che viveva nelle aree di rischio era più numerosa nel nord est (1.629.473 cittadini), seguito dal sud (1.623.947), dal nord ovest (1.276.961), dal centro (1.081.596), e dalle isole (90.794).
Il rischio coinvolge grandemente le scuole, una su dieci, le strutture ospedaliere, molte fabbriche industrie, moltissimi negozi e attività commerciali. Ma il dato che appare assolutamente sconcertante, dopo ovviamente le 4000 vittime, è quello economico: secondo Legambiente, il costo complessivo dei danni provocati in Italia da terremoti, frane e alluvioni negli ultimi vent’anni è di 242,5 miliardi di euro, circa 3,5 miliardi l'anno.
Una situazione ogni anno sempre più esplosiva fra degrado, abbandono, cementificazione, abusivismo, mancanza di manutenzione, incuria delle pubbliche amministrazioni che non avendo fondi a sufficienza tralasciano, colpevolmente, la cura del proprio territorio, inesistenza di un piano nazionale che inevitabilmente va ad aggiungersi ai sensibili cambiamenti climatici.
Possibili soluzioni.
Mandare definitivamente in pensione la politica edile e le concezioni urbanistiche degli anni cinquanta e sessanta, giunte incredibilmente fino a noi; investire in sicurezza, sostenibilità ambientale, nuovi materiali; dotare le amministrazioni periferiche dei fondi necessari invece che tagliarli, per la giusta manutenzione. Organizzare un organico servizio nazionale circa il rischio idrogeologico, sulla scia di quanto faticosamente si sta cominciando a fare per quello sismico. Insomma smettere di provare a rimediare dopo ogni disastro cominciando a prevenirli, cosa che ci costerebbe molto in meno. Infine pensare la cura del territorio come una delle prime fonti di ricchezza del nostro paese, connettendola alla salvaguardia delle tradizioni e locali, dei paesaggi e alla valorizzazione del turismo e dei beni artistici e architettonici.
Il governo Renzi e tutti i futuri governi non hanno più alibi a proposito della inderogabile necessità di mettere in sicurezza il territorio.