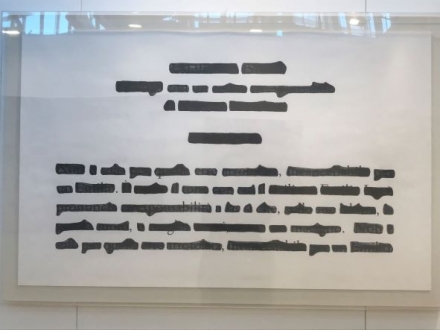Cafarnao. Caos e miracoli
Nadine Labaki ci porta in Libano nell'inferno degli invisibili affidandosi alla potenza del cinema.

Il termine cafarnao, nella lingua italiana, indica un luogo pieno di confusione; tale significato deriva dal nome dell’antico villaggio sul lago Tiberiade dove Gesù predicò e compì miracoli.
Il dodicenne Zain però, nella sua esistenza, di miracoli non ne ha veduti mai.
La vita non gli ha dato nulla, nemmeno un atto di nascita o un documento di identità. Non esiste.
Quando ne facciamo la conoscenza è in tribunale perché ha fatto causa ai suoi genitori; l’accusa è di averlo fatto nascere.
D’altra parte sino a quel momento non ha conosciuto altro che dolore, disperazione, solitudine, povertà e privazioni.
Le sue giornate le passa in strada insieme ai fratelli e sorelle cercando disperatamente di racimolare qualche soldo. Guarda con occhi pieni di desiderio il pulmino che riporta a casa quei fortunati che possono andare a scuola. La sua infanzia gli è stata rubata, nonostante la splendida sequenza d’apertura in cui lo vediamo giocare. Forse un sogno, perché Zain è già grande, lavora, non va a scuola e sembra essere più lui ad occuparsi della famiglia rispetto a suo padre e a sua madre.
In particolare della sorella Sahar che verrà data in sposa ad Assadd, proprietario di un negozio di alimentari e del tugurio dove vive il bambino.
La disperata dipartita della sorella sarà l’ultima goccia, quella che spingerà Zain a fuggire di casa.
Sul suo cammino incontrerà Rahil, un’emigrata proveniente dall’Etiopia con il permesso di soggiorno in scadenza che abita in una bidonville insieme al suo piccolo figlio Yonas.
Quando la donna sparirà toccherà a Zain occuparsi del bambino, sino a quando un atto di feroce vendetta non lo porterà in carcere.
L’idea di un bambino che accusa i suoi genitori per averlo messo al mondo condannandolo ad una non vita, potrebbe sembrare un artificio retorico poco credibile.
Retorica e credibilità, sono queste le accuse che in molti hanno mosso all’opera di Nadine Labaki.
In realtà ci sono (forse) solo due momenti in cui il film cede alla retorica, uno è nell’uso della colonna sonora quando Zain compie la sua “vendetta” e l’altro è nel finale che lascia aperta la porta ad una flebile speranza che, soprattutto per quanto riguarda Rahil ed il suo bambino, appaiono figlie di una vicenda che lascia adito a qualche dubbio proprio per quanto riguarda la verosimiglianza.
Si tratta però, a nostro avviso, di accuse infondate.
Cafarnao, infatti nasce da un’indagine lunga tre anni che ha portato Nadine Labaki ad esplorare e conoscere le zone più degradate di Beirut, le stesse dalle quali ha preso i suoi interpreti; persone che, come nella migliore tradizione neorealista, provengono dalla strada e che hanno vissuto sulla loro pelle i drammi narrati nella finzione.
Zain al-Rafeea, lo straordinario bambino protagonista del film, ad esempio, è un profugo siriano cresciuto nei campi per rifugiati in Libano che solo grazie al film ha potuto rifarsi una vita in Norvegia dove, finalmente, è anche potuto andare a scuola.
Quello che invece, secondo noi, ha urtato la coscienza di chi ha mosso tali accuse al film è l’assoluta fiducia che dimostra la regista nelle capacità intrinseche del cinema.
Se c’è un peccato in Cafarnao è quello di essere un bel film che stritola la pancia dello spettatore gravandolo di un peso che si porterà a casa grazie al suo stile.
Siamo tuttavia ben lontani dal taglio di film quali The millionaire.
Nadine Labaki ha scelto di girare un film che ha il sapore del cinema verità, camera a mano ad altezza di bambino, riprese frenetiche, pedinamento dei personaggi che ricordano la lezione di Zavattini; fotografia grigia e cupa capace di aprirsi a squarci di poesia nelle riprese aeree o nell’inquadrare l’alba sul mare, unico momento di respiro in film asfissiante tanto quanto il tugurio-prigione nel quale sono costretti a passare le loro giornate Zain e Yonas.
Il suo è un viaggio, dai toni quasi picareschi, che ci porta sempre più nelle viscere dell’inferno.
Per quanto possa sembrare assurdo Cafarnao conserva il sapore dell’innocenza infantile, anche di chi se l’è vista rubare.
Nadine Labaki possiede la rara dote di raccontarci una realtà che colpisce al cuore con un tocco comunque lieve e che proprio per questo colpisce ancora più a fondo.
Il suo sguardo si limita ad osservare e registrare, non formula atti di accusa; come ogni grande regista sa che basta la potenza delle immagini ad inchiodarci alla poltrona e alle nostre responsabilità.
Altro che retorica, se usciamo col cuore pesante è per quello che abbiamo visto, mostrato con lievità nella sua potenza esplosiva.
Una realtà di invisibili ed emarginati. Di sotterfugi per tirare a campare.
Di uomini scarafaggio soli, di sguardi indifferenti alla povertà, di bambini rubati e venduti, costretti a trascinare la loro esistenza tra strade polverose, mentre vendono poche cose ai semafori, sognando improbabili fughe in Svezia che in realtà saranno viaggi della disperazione affidati a trafficanti di uomini su gommoni destinati ad affondare; oppure destinati a finire in disumane carceri sovraffollate dalle quali levare la loro voce d’accusa per chi li ha messi al mondo senza coscienza.
Spesso si sente dire che ci sono film necessari. Ma Cafarnao è soprattutto un bel film.
Ed è questa la sua colpa.
EMILIANO BAGLIO