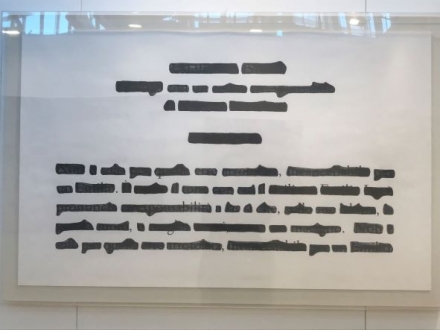Festa del cinema di Roma. Tre film della Selezione ufficiale. Tout nous sépare. And then there was light. Valley of shadows

Festa del cinema di Roma. Tre film della Selezione ufficiale.
Tout nous sépare. Regia: Thierry Klifa.
Non basta Catherine Deneuve a fare un buon film, così si potrebbe riassumere Tout nous sépare, film che non si capisce bene che strada voglia percorrere.
Julia (Diane Kruger), ragazza dell’alta borghesia è succube del suo amore verso il delinquente Rodolphe (Nicolas Duvauchelle). Quando Julia commetterà un atto irreparabile sarà la madre Louise (Catherine Deneuve) ad intervenire mostrando tutto il proprio sangue freddo. Finché le due non finiranno vittime del ricatto di Ben (interpretato dal rapper Nekefeu), amico fraterno di Rodolphe.
Tout nous sépare sfodera le caratteristiche tipiche del noir francese. Un sottobosco criminale, l’ambientazione nella provincia costiera, il contrasto tra l’alta borghesia e la piccola criminalità. Il tutto condito dall’immancabile amour fou tra Julia e Rodolphe e dallo scontro tra madre e figlia. Quando entra in scena Rodolphe sembra proprio che il film seguirà questa strada sino in fondo ma a questo punto il regista Thierry Klifa si impantana da solo decidendo di riempire di ambiguità il rapporto tra il ricattatore e Louise. A questo punto lo spettatore non capisce più quali siano le intenzioni del film. Il legame tra i due non può essere liquidato come un classico caso di Sindrome di Stoccolma nel quale la ricattata subisce il fascino del ricattatore e neanche vogliamo credere ad un’improbabile attrazione amorosa. Rimane dunque la domanda, di cosa voleva parlarci Klifa con il suo film? Di una borghesia altrettanto criminale che finisce con l’empatizzare con la delinquenza comune scoprendosi in fondo simile? Di una donna che riscopre la libertà attraverso gli occhi in fondo innocenti e puri del proprio ricattatore? Qualunque sia la risposta il risultato è un film deludente e noioso.
And then there was light. Regia: Tatsushi Ōmori.
Nobuyuki (Arata Iura), Tasuku (Eita) e Mika (Kyoko Hasegawa) vivono nell’isola di Mihama. La loro vita cambia per sempre quando uno tsunami colpisce l’isola. Venticinque anni dopo Tasuku ricompare nelle loro vite e comincia a ricattare i due, che da giovani erano stati amanti, sostenendo di avere le prove dell’omicidio compiuto da Nobuyuki per difendere Mika.
And then there was light procede per 138 lunghissimi munti che sembrano non finire mai ammassando tematiche e carne al fuoco tra immagini che vorrebbero essere suggestive, esplosioni di violenza, triangoli amorosi e scene di vita quotidiana. Diciamolo subito la cosa migliore del film è la strepitosa colonna sonora affidata a quel mago della techno che è Jeff Mills.
Per il resto, come già detto Ōmori affastella temi su temi. Si parte con il racconto di un’infanzia non proprio felice visto lo stupro di Mika e le violenze che Tasuku subisce dal padre. Con l’età adulta il film ci presenta una storia di amore malato. Tasuku infatti è l’amante della moglie di Nobuyuki, anche se, come scopriremo strada facendo, il suo unico interesse è ricontattare l’amico di un tempo per ricattarlo. Tuttavia siamo ben lontani dalle strade tipiche del noir. Il film piuttosto sembrerebbe voler essere un atto di accusa nei confronti della vita del Giappone dei nostri giorni.
Il ritratto che ne esce fuori per molti versi è terrificante. Nobuyuki manda avanti un matrimonio alla cui base c’è la menzogna, dal momento che entrambi i coniugi sono fedifraghi, e nel quale c’è una violenza soffocata che da un momento all’altro potrebbe esplodere. Nel quadro non manca neanche il tema della pedofilia giacché la figlia della coppia è vittima di molestie. Le cose non vanno meglio se si prende in esame Mika, descritta come una femme fatale incapace di provare sentimenti, fredda e calcolatrice. Lo stesso, infine, vale per Tasuku, poco più che un derelitto ancora dominato da un padre violento ed ubriacone. Insomma la descrizione del Giappone che ne viene fuori è sconsolante. Non mancano ovviamente le esplosioni di violenza e gli omicidi brutali anche se i momenti migliori del film sono quelli quasi onirici e scherzosi in cui si descrive il rapporto tra Nobuyuki e la figlia. Peccato che l’analisi sociale offerta sia diluita in un film francamente troppo lungo e sfiancante che troppo spesso si affida ad immagini che vorrebbero essere poetiche e finiscono con l’essere incomprensibili.
Valley of shadow. Regia: Jonas Matzow Gulbrandsen.
Non è una vita facile quella del piccolo Aslak. Il fratello maggiore è un drogato destinato ad una brutta fine che da tempo ha abbandonato casa. La madre Astrid è distrutta dal dolore e per finire qualcosa, nelle notti di luna piena, uccide le pecore nei dintorni. Forse potrebbe trattarsi di un licantropo che vive annidato nel cuore dell’oscura foresta che domina il paesaggio. Sarà proprio Aslak ad avventurarsi in questo cuore di tenebra alla ricerca del proprio cane.
Valley of shadow vorrebbe chiaramente essere il racconto di un viaggio iniziatico durante il quale il piccolo protagonista si trova a dover affrontare le proprie paure diventando grande. Si tratta però di un progetto che è rimasto sulla carta e del quale, onestamente, nel film non c’è traccia. Gran parte del lungometraggio consiste nel girovagare del ragazzino sperduto nella foresta alla ricerca del proprio animale tra paesaggi meravigliosi ed una colonna sonora che vorrebbe essere evocativa. Il senso del film dovrebbe quindi scaturire dal potere evocativo delle sue immagini. Altrettanto simbolico è l’incontro tra Aslak ed un uomo misterioso che vive nel cuore della foresta, una figura che in parte richiama l’uomo nero o forse è solo il frutto dell’immaginazione del ragazzino che proietta in esso la figura assente del fratello maggiore. Sinceramente non è che si capisca più di tanto. Così come non si capisce il senso generale del film. Valley of shadow forse vorrebbe essere un film che invita a scendere a patti con i propri mostri imparando ad accettarli e a convivere con essi. Forse è questo il senso del gesto finale di Aslak che di notte si avventura nel bosco e ruba la carne avvelenata lasciata lì per uccidere chi sventra le pecore. Se lo scopo del regista era questo, gli consigliamo di vedersi The babadook che tratta l’argomento decisamente meglio. Se invece Gulbrandsen voleva affascinare lo spettatore tramite emozionanti immagini della natura selvaggia, la nostra impressione è che anche in questo caso ha fallito miseramente. Bisogna essere dei grandi registi per compiere simili operazioni e possedere un apparato estetico che in questo film manca del tutto.
EMILIANO BAGLIO